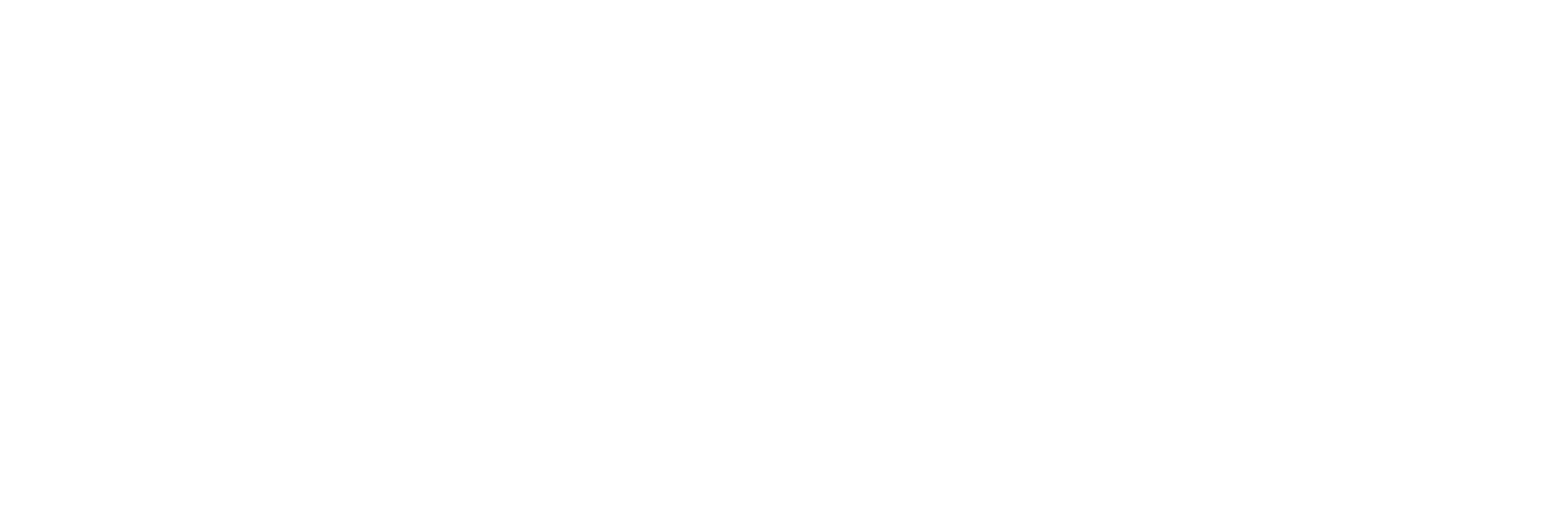1. Il caso concreto e la norma contestata
Con l’Ordinanza n. 64/2025, la Corte di Giustizia Tributaria (Cgt) di secondo grado del Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale sull’articolo 21-bis del D.Lgs. 74/2000, che disciplina l’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio tributario. Il caso nasce da un accertamento dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società che l’Amministrazione riteneva fittiziamente residente in Svizzera, contestando quindi un’omessa dichiarazione dei redditi in Italia. In sede di appello tributario, la società ha fatto valere una sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché "il fatto non sussiste", chiedendo che questa venisse recepita con valore di giudicato nel procedimento tributario in base alla suddetta norma.
La disposizione oggetto della questione prevede infatti che, quando vi sia identità soggettiva e oggettiva tra il giudizio penale e quello tributario, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata all’esito di dibattimento produce effetti vincolanti anche nel processo tributario, relativamente ai fatti accertati.
2. I dubbi di costituzionalità sollevati dalla Corte di Giustizia tributaria
La Cgt solleva dubbi di costituzionalità su diversi piani. In primo luogo, evidenzia una potenziale violazione dell’articolo 24 della Costituzione, poiché l’Agenzia delle Entrate, non essendo parte del giudizio penale, non avrebbe modo di far valere il proprio diritto di difesa rispetto all’interesse fiscale. Il giudice tributario osserva inoltre che, anche qualora l’Agenzia si costituisse parte civile nel processo penale, non potrebbe farlo per tutelare l’interesse alla riscossione dei tributi, ma solo per altri danni, rendendo quindi inadeguata la tutela sostanziale. Neppure il Pubblico Ministero, secondo l’ordinanza, potrebbe considerarsi portatore dell’interesse erariale alla riscossione.
Il secondo profilo critico riguarda una presunta disparità di trattamento tra reati tributari e reati comuni. Infatti, ai sensi dell’articolo 652 del Codice di procedura penale, la sentenza penale assolutoria può avere effetti extrapenali (civili o amministrativi) solo se il danneggiato sia stato parte del processo penale o abbia avuto la possibilità di parteciparvi. In ambito tributario, invece, il meccanismo dell’articolo 21-bis sembrerebbe operare automaticamente, anche in assenza di simmetria partecipativa, creando così un’irragionevole disparità.
Infine, viene rilevata una disparità anche rispetto alle sentenze penali di condanna, le quali non hanno valore automatico nel processo tributario a favore dell’Agenzia, a differenza di quanto avverrebbe con le assoluzioni per il contribuente.
Tuttavia, gli autori dell’articolo sottolineano che simili asimmetrie sono già presenti nell’ordinamento tributario, spesso a danno del contribuente, senza che ciò abbia mai suscitato dubbi di costituzionalità. Inoltre, l’efficacia della sentenza penale è limitata ai fatti materiali perfettamente coincidenti tra i due giudizi, e viene riconosciuta solo quando l’accertamento penale è avvenuto mediante dibattimento, garantendo così una valutazione più approfondita rispetto a quella indiziaria tipica del processo tributario.
L’intervento della Corte Costituzionale potrà chiarire i limiti applicativi dell’articolo 21-bis, bilanciando il principio del giusto processo e la tutela degli interessi erariali.